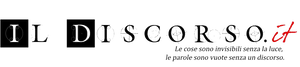Pubblicata la raccolta di poesie nel dialetto di Castel Bolognese dal titolo “Quand ’ca sémia burdèl” (“Quando eravamo ragazzi”) di Domenico Minardi, con prefazione di Enzo Concardi e postfazione di Pier Guido Raggini, nella prestigiosa collana “Alcyone 2000”, Guido Miano Editore, Milano 2023.
«Sfogliando la tua vecchia agenda dove negli anni hai fissato le immagini più significative della tua vita, abbiamo scelto alcune delle tue più belle poesie e le abbiamo raccolte perché la nipote Daniela, quando le leggerà, possa conoscere la sensibilità del nonno» (Lucia e Giuliano, Natale 1980). Queste affettuose parole si leggono nell’incipit del libro di Domenico Minardi Quando eravamo ragazzi e ne spiegano la genesi letteraria: sarà infatti proprio la cara nipote, divenuta la professoressa Daniela Romanelli, a commissionare la pubblicazione dei testi alla Casa Editrice Guido Miano. Dalla data della dedica ad oggi sono trascorsi oltre quarant’anni, ma evidentemente il tempo non è nulla di fronte ai sentimenti autentici che albergano nei cuori delle persone veramente legate alla memoria dei propri cari: e questo libro, a sua volta, è assolutamente un’opera in cui la memoria è la protagonista principale.
Si legge anche, nel sottotitolo, che si tratta di Poesie nel dialetto di Castel Bolognese(tradotte qui ovviamente in italiano). Siamo dunque di fronte ad un genere letterario, da sempre classificato a parte rispetto alla produzione nella lingua del sì, senza che ciò - aggiungo io - debba necessariamente implicare un pregiudizio di valore. Indica, piuttosto, questa caratteristica idiomatica, la presenza di radici identitarie ben salde che affondano nella propria terra e nella propria gente, oltre che essere il modo di pensare e di vivere del microcosmo a cui appartengono.
Domenico Minardi (Castel Bolognese, 1923 - ivi, 2002) si era laureato in Medicina e Chirurgia veterinaria all’Università di Bologna, esercitando la professione fino agli anni ‘90. Ha insegnato matematica e scienze nelle scuole medie statali. Si è sempre dilettato a comporre e recitare poesie dialettali: c’è dunque da presupporre che in lui l’anima scientifica abbia sovente convissuto con l’anima umanistica e che i due aspetti culturali, spesso, ma a torto, messi in contrapposizione, nella sua esistenza, invece, si sono armonicamente sviluppati, integrandosi dialetticamente. Come adesso vedremo, nell’analisi critica delle sue liriche, le corde del sentimento sono in ogni composizione toccate delicatamente e con pudore, ovvero non gridate ed ostentate, ma chiaramente espresse perché ritenute vere, appartenenti alla sua storia, vissute senza alcuna retorica o nostalgico vittimismo.
Il punto di partenza di ogni lirica del poeta è sempre il passato, il rimpianto di ciò che è stato e che non potrà mai più essere: questa chiara coscienza del lavorio deterministico del tempo suscita in lui stati di commozione, nei quali il lettore può sentirsi coinvolto se ha vissuto le stesse vicende esistenziali, oppure se con l’immaginazione cerca di entrare nel mondo interiore dell’autore. Va da sé, come si diceva in precedenza, che la rivisitazione del passato implica automaticamente un viaggio, degli itinerari nelle dimensioni memoriali, letterariamente paragonabili alla proustiana ricerca del tempo perduto.
Altre componenti non entrano in tale scrittura, per cui si potrebbe pensare ad un’ispirazione monotematica - ed in parte è così - ma solo in parte, poiché Minardi allarga poi lo sguardo sulla civiltà contadina, la campagna, l’infanzia come da lui vissute, certamente, ma da individuali le sue immagini si trasformano in universali, storiche di uno spaccato della nostra società, dal momento che hanno rappresentato una fase del nostro vivere.
Va sottolineato ancora che il carattere fondamentale della sua poesia trae prevalentemente origine da esperienze autobiografiche, dunque soggettive, tuttavia trasformate in temi e miti comuni e ricorrenti anche in autori maggiori della nostra letteratura: il mondo agreste e sensitivo della natura, con gli affetti familiari e l’attaccamento alla terra di pascoliana elaborazione; l’idealizzazione della giovinezza come l’età della felicità temporanea e illusoria, presente negli idilli leopardiani e nella narrativa di Pavese. Ed inizierei proprio dai ricordi dell’infanzia e giovanili la disanima particolare dei suoi testi. C’è la titolazione di una lirica, Quando eravamo ragazzi - che non a caso dà il titolo alla raccolta - paradigmatica di altre dello stesso genere, che racchiude il bisogno profondo, sentito, quasi una necessità vitale, di riandare indietro nel tempo, di rivivere ad occhi aperti quegli anni e quei sogni: nelle sei quartine della poesia agili immagini e pennellate di espressioni visive ci raccontano di una capanna di lamiera sopra un fosso, il centro d’incontro dei ragazzi della contrada, centro di giochi infiniti e un drappo sventolava sopra di essa, come una bandiera di riconoscimento. Tutto era bello, dice il poeta: fare a botte per un amico, rincorrere il treno a vapore, cantare nel silenzio della notte, cacciare con le fionde, divertirsi con poco. Ora di quei ragazzi qualcuno non risponde all’appello, se li è portati via la morte; ma ecco la speranza: «…in alto sulla capanna / c’era un pezzo di latta con su stampato un cuore: / il cuore dei ragazzi della mia Romagna / che dopo morti sembra che vivano ancora».
Un’altra rievocazione gioiosa dei giochi d’infanzia la incontriamo in Speranza: il poeta ricorda un gran correre spingendo una giostrina e sempre si correva per guadagnarsi un bel giocattolo, l’oggetto preferito di quell’età. E nell’ultima strofa una semplice riflessione ci svela la sua visione ottimistica della vita: «…Tutto quel correre, da grandi dura ancora / perché nella vita manca sempre qualche cosa: / quel giro che da ragazzi facevamo allora / dura sempre, ed è sempre bello!».
Nelle sei quartine de La statuina le memorie del poeta assumono toni pascoliani, legati alla poetica delle piccole cose, del ‘fanciullino’ e degli affetti domestici: ne è occasione il ritrovamento in soffitta, dentro una vecchia scatola, di una statuina rotta del presepe. Ciò lo riporta ai Natali trascorsi, alle battaglie con le palle di neve, ai primi biglietti d’amore nascosti nelle pagine di un libro, alle calze appese al camino per l’Epifania, alla mamma che gli rimboccava le coperte… Una ricostruzione delle atmosfere natalizie piena di pathos e di emozioni, per successivamente ricostruire in tre versi le gioie della vita: «... e poi ecco la pagina più bella: / la mia donna e poi le carezze della mia bambina / e l’interminabile rosario della nonna».
La cascata dei ricordi di Domenico Minardi è inesauribile: ora è la volta della Vecchia Pocca, «una località della campagna di Castel Bolognese, con un bel bosco, una radura per i balli e una fresca fontana di acqua sulfurea» dice la nota a piè di pagina. Era una meta frequentata dai ragazzi del borgo, sempre «in bolletta» sì, ma a vent’anni avevano quello che era necessario per essere felici: la voglia di cantare, le ragazze, l’amore. Ora è rimasta solo la fontana, e la consapevolezza, con «il groppo in gola», che quell’età e quel mondo non potranno più tornare.
Quando eravamo ragazzi, intesa come scrittura del ritorno alla giovinezza, è il binario sul quale si muove il convoglio di Domenico Minardi anche quando l’accento si sposta maggiormente sul tema del legame con la terra natale: esaminando alcune liriche di questo genere risulterà subito evidente il vincolo con le radici. La voce del gallo risuona nella campagna e diviene occasione per rievocare le origini mai dimenticate: «…Oh, bel gallo della cavéja canterina / fammi contento, fammi tornare fanciullo / fa che baci la terra di Romagna, / che riveda il campanile della mia Castello!». Campagna, nell’ottava d’esordio, è lirica realistica ed efficace, con le sue immagini rudi ed evocative, per stendere un elogio alla civiltà contadina, poiché è lì, in mezzo a quel mondo, che si trova l’armonia e la felicità degli affetti: «Una bicocca fatta da cent’anni, / una porta sgangherata, due finestrelle, / un nastro rosso per tener lontano il maligno, / un pozzo nell’aia, un abbeveratoio, un acquitrino, / una pagliaia con due buchi in mezzo, / un aratro vecchio, una botte già sfasciata, / colombi che si levano con degli svolazzi, / una scrofa nel fango là sdraiata...». E dopo tale elencazione sparpagliata di oggetti alla rinfusa, nell’altra ottava che chiude il canto, il poeta afferma con candore: «... basta una carezza fatta di sera / per essere contenti e vivere in fortuna!».
Le liriche Ritorno e Ritorno in Romagna coniugano il verbo forse più caro all’autore: rivisitare i luoghi natii, le favole in cui allora si credeva, riavvicinarsi al calore dell’antico casolare, risentire il profumo della campagna, ascoltare il cuore della Romagna. E sentirsi in amicizia con le piccole creature della natura, il grillo, la lucertola, la cicala, la cavalletta: un mondo pre-industriale, pre-tecnologico e pre-virtuale, amato così intensamente da essere rimasto attaccato profondamente all’essere, alla materia e allo spirito di questo suo figlio.
E ancora, infine, ritornare Fuori nella notte a contemplare «... il colore del sangue della tua Romagna, / della terra che ti aspetta per accoglierti, / della terra che ti vide correr bambino». Qui il poeta vive un rapporto madre-figlio con la sua terra, che potrebbe provenire quasi da un substrato onirico, se non addirittura psicanalitico, o, più semplicemente, riesce ad essere se stesso solo in tale dimensione.
L’amore che ha sempre sorretto la vita di Domenico Minardi si è concretizzato, oltre che nel rapporto coniugale, anche con la nascita della figlia Lucia e con la venuta della nipote Daniela, presenze importanti che lo hanno ispirato poeticamente: ne abbiamo qui testimonianza nelle liriche A mia figlia e A Daniela. Emerge dai versi un grande senso di tenerezza e protezione nei loro confronti ed anche la sincera ammissione di un errore, cioè di averle avvolte troppo nel mondo delle favole per tenerle al riparo dai mali del mondo: l’affetto col quale è stato ricambiato è segno invece di un modello educativo vincente.