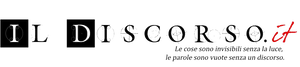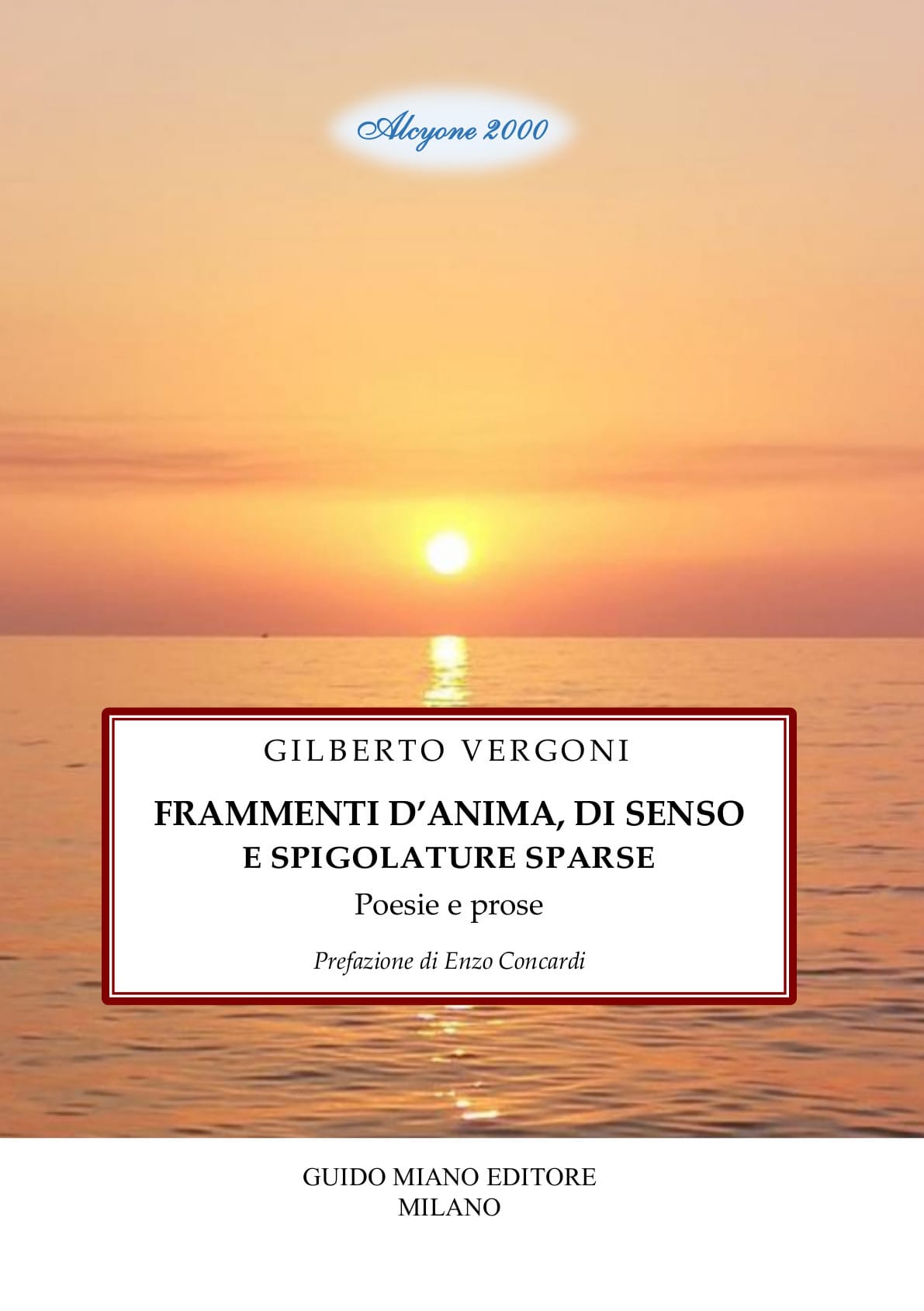Questo interessante lavoro di Gilberto Vergoni indirizza il lettore, fin già dal titolo – emblematica ed estrema sintesi della sua ricerca esistenziale e spirituale – sulla strada di un cammino personale ed interiore, all’interno della problematica fondamentale della condizione umana, ossia l’indagine sulle origini, il significato e il destino della vita, tout court: è il terreno propedeutico al senso religioso del nostro essere che, tuttavia pare non sia raggiunto nei testi elaborati dall’autore nel presente libro, anche se talvolta certamente egli s’avvicina molto ad esso o, quanto meno, nasce in lui il desiderio di un simile approdo. È la perenne domanda che qualifica antropologicamente l’uomo e che ha appassionato le menti pensanti d’ogni epoca storica. Vergoni, tuttavia, scopre che il cammino della conoscenza attraverso la ragione, la scienza, la razionalità – che gli ha consentito di conseguire successi brillanti come neurochirurgo – non è sufficiente per dipanare il mistero della nostra presenza sulla Terra: rimane allora in attesa, con una onestà intellettuale che gli va riconosciuta, di quella luce che la dea ragione pare non possa definitivamente sprigionare, tanto da definirsi paradossalmente con un ossimoro: «…Io mi sono sempre ritenuto un filosofo cristiano cattolico non credente» (Un giorno a Cambridge, Novembre 2002).
Il desiderio di verità è in lui una sete mai spenta, anzi, sempre più urgente e quotidiana. Sotto questo aspetto possiamo arrischiare due accostamenti letterari, non tanto formali quanto contenutistici, con Leopardi e Pascal, due autori altrettanto insoddisfatti della ragione umana. È nota la “conversione filosofica” leopardiana che lo porta dalla “ricerca del bello” alla “ricerca del vero”, fase in cui scopre gli inganni e le illusioni della vita, sfociando in un pessimismo disperante: ciò invece non accade in Vergoni, che conserva una visione aperta alla speranza, circondato dagli affetti familiari (si leggano le liriche Figlia, Figlio, Era di maggio, Elena, Avrei voluto che tu fossi, Mamma, Silvia …) e consapevole dell’utilità umana e sociale della sua professione. A proposito dell’indagare doloroso del Leopardi sono rimasti celebri alcuni versi del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (1831): «Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai,/ silenziosa luna? /…/ Dimmi, o luna: a che vale/ al pastor la sua vita,/ la vostra vita a voi? Dimmi: ove tende/ questo vagar mio breve,/ il tuo corso immortale?».
Anche la vicenda pascaliana è nota. Matematico e fisico, si converte al Cristianesimo, scommettendo sull’esistenza di Dio, scrivendo la sua apologia ne I Pensieri (1670), attuando il “salto” nella fede in modo irrazionale: «Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce» (Pensiero 277). Questo è il “salto” che nel nostro autore non è ancora avvenuto, ma di cui si trovano le premesse in diverse sue liriche e meditazioni, tratte da Frammenti d’anima, di senso e spigolature sparse, tra cui: «Verità, dove sei?/ No, non splendi in mezzo al prato./ Come sui monti all’inesperto/ ciò che copre l’orizzonte sembra la cima,/ come l’alta onda t’illude esser l’ultima/ anche nell’infinito oceano,/ così l’occhio miope dell’uomo/ che non sa,/ non vede.// Verità, dove sei?/ Quante lacrime ancora dovranno lavare,/ amare e salate,/ gli occhi dell’uomo perché veda?/ Dall’alto tutto sembra pace. Non c’è ragione per il male./ Dall’alto non si sente il grido e non si distingue/ il colore, l’accento, l’odore. / Né l’altare. / Dio, perché sei così lontana?» (Verità, dove sei?). Ed anche: «Scrivo di me, della vita;/ ho cercato e pensavo d’aver capito,/ ma non so perché il mare è salato!/ L’acqua è dolce e scende e scorre./ E così la vita.// Forse scrivo per essere dove non sono/ o forse perché vedo dove non guardo./ Come in un sogno che sembra più vero/ perché altro e altrove./ Là,/ dove andrò e dove andrà la mia mente.// Il dove,/ l’era,/ il sarà,/ sono confusa percezione che/ l’adesso dilata./ Resta solo il ricordo di un’emozione./ E non so perché il mare è salato!» (Perché).
Si nota in tali testi la metrica a forma libera scelta dall’autore, anche se nel complesso della struttura letteraria prevalgono terzine e quartine; l’uso di anafore, tecnica che rende più efficaci i ritmi di alcuni versi; l’utilizzo della metafora (frequente è quella del mare) che è quasi un’esca per il lettore, sollecitato così a cercarne l’interpretazione; la forma interrogativa, quasi d’obbligo in una poetica di ricerca a domanda e senza risposta. Un’altra scelta importante effettuata nel libro è l’alternanza fra poesia e prosa: ciò mi pare giustificato dal fatto che, mentre la poesia è soprattutto sintesi, la prosa tende maggiormente verso l’analisi, forma scritturale che serve all’autore per approfondire le sue riflessioni e dissertazioni filosofico-ontologiche, senza rinunciare a qualche abbozzo narrativo, ma anche prendendo di petto le questioni dal punto di vista teoretico per inviare messaggi chiari e definibili. La letteratura di Vergoni ha un’origine eminentemente autobiografica, ma, quando egli passa dalla visitazione dei sentimenti – dove sa comunicare con abilità stilistica le emozioni, le sensazioni, gli stati d’animo – o dalla contemplazione della natura, alla speculazione più intellettuale, il referente dell’io si trasforma in una profonda proiezione universale, data la sostanza cosmica delle tematiche prese in considerazione, che riguardano l’essere metafisico e storico, la mondanità e l’escatologia, la condizione femminile nella società odierna ed accattivanti tuffi nella dimensione memoriale, dove appaiono anche misteriosi dèjà vu.
Due pagine essenziali, per capire l’approccio dell’autore con la realtà, sono quelle scritte sotto il titolo: Razionale sentimento, forse…, nelle quali l’avventura umana, la storia dell’umanità e la loro interpretazione, vengono narrate all’insegna del mito, a partire dalla cacciata dall’Eden, la caduta iniziale che ci ha condannati ad una nostalgia perenne di ciò che abbiamo perduto: la felicità, la libertà e la conoscenza. Lo afferma egli stesso con queste parole: «Forse è per questo che la vera storia dell’uomo, quella immutabile del suo animo, è stata scritta e tramandata nel mito…». E così rievoca il destino di Ulisse, che in realtà non ha mai lasciato Itaca, perché è rimasta sempre nel suo cuore; quello del dio Osiride, fatto rinascere da Iside ricomponendo i frammenti del suo essere, paragonando Osiride alla verità e la funzione di Iside a quella che dovremmo assumere noi, nel nostro mondo. Vergoni si spinge ad affermare che: «…forse, la scintilla della conoscenza che ancora alberga in noi, meglio si vede nel sogno e, forse, è nel sogno che la vera vita parla e ci indica “ciò che è”». Quindi la dimensione onirica è quella che ci può suggerire maggiormente la vera conoscenza, ovvero: «Chi siamo, da dove veniamo; dove stiamo andando». Ma tutto è subordinato a quel forse, che lascia le questioni in sospeso.
E, simili a queste due pagine in prosa, troviamo diverse liriche in cui emerge il bisogno del ritorno a casa, la ricerca dell’identità, il destino dopo la morte, la vita che se ne va, la solitudine, il significato del Tutto. La Casa, nella visione del poeta, assume plurimi significati: il nucleo centrale degli affetti; il luogo dove si aspira a tornare dopo un viaggio; ma è soprattutto l’origine con la quale si brama il ricongiungimento definitivo: «Dov’è la mia casa, la nostra casa? … Quando mi sentirò di nuovo a casa? … Dove stiamo dunque andando se non sempre verso casa?». Il credente direbbe: «Ritorno alla casa del Padre». Il poeta presta la voce a Reyhaneh Jabbari, donna iraniana condannata a morte per l’uccisione di un uomo che voleva violentarla: anch’essa prega e spera di ritornare nella casa divina: «…Voglio che i miei occhi ormai chiusi/ vedano e vadano col vento/ perché mi porti/ là dove il Giudice sa». Nelle pietre di antiche chiese si compie «il mistero dell’essere qui,/ testimone di cose che non so/ ma che porto dentro»: è ancora il sentire l’Altro, senza saperlo riconoscere. E il chiedersi i perché comporta anche il trovarsi nel deserto: «…Vivo nella vertigine della solitudine/ di chi vede e sente/ negli indifferenti attimi che passano...» (Guardando il silenzio). La partita del senso sembra persa («... di un senso che non c’è…»), ma «alla ricerca infine di un senso» egli è pronto comunque a sperare contro ogni speranza (Sogni nel sale del mare).
Bisognerebbe poi leggere, sul tema della morte che si preannuncia, tutta l’allegoria della poesia Scacco matto, che può rievocare le sequenze del film di Ingmar Bergman Il settimo sigillo, dove un cavaliere sfida la Morte ad una partita a scacchi per rimandare il suo destino; nella lirica di Vergoni i primi tre versi ne riformulano lo scenario: «Mi ha sfiorato il freddo sussurro di chi pensavo Sorella/ credendo anch’io di poterci giocare/ coi labili schemi, regole e strategie degli scacchi…». Ovviamente la conclusione è tutta a favore della Straniera, che sempre dà scacco al re: «Non capivo che il tempo/ semplicemente per Lei non è!». Altre frecce nell’arco della poetica vergoniana – come già accennato – sibilano nella memorialità dell’infanzia: Leggero come un amico ci narra del compagno di giochi, presenza indispensabile di tante giornate; Festa rievoca le suggestioni dell’età più bella e spensierata: «…Come lo scirocco che vien da lontano,/ il ricordo riscalda/ sciogliendo il cuore e finalmente le labbra/ in un sorriso sereno e, per un po’, senz’affanno»; anche Effimera brezza ci conduce nel passato, «di quando, bambino, la vita/ per quell’attimo che è, era immortale».
Ci soffermiamo ancora sull’aspetto d’ispirazione naturalistica dentro la poetica di Gilberto Vergoni, citando, ad esempio, Tappeto di foglie, delicata lirica dell’ambiente boschivo autunnale, contesto accattivante per un incontro d’amore: «…Il sapore rimase in un attimo immenso./ Senza ricordi./ Solo un inebriante sapore di te». E il verso anafora «abbiamo camminato su un tappeto di foglie» danza fra le strofe come il ritornello di una canzone. Ci sarebbero anche Rosa solitaria, Mare e altro… ma il nostro spazio è terminato, quindi invitiamo il lettore ad impossessarsi di questi frammenti e di queste spigolature, che meritano una visitazione per il livello estetico e culturale di notevole spessore.
Prefazione di Enzo Concardi