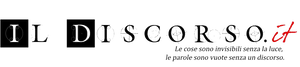Jules (Fiona Dourif) è una giovane sensitiva, facente parte del team operativo della Skeleton Crew, una trasmissione televisiva che indaga su fenomeni paranormali. Il suo ruolo principale nella squadra è quello di selezionare i luoghi più “promettenti” dove andare a indagare, grazie a una sua particolare sensibilità per la presenza di entità e fenomeni occulti.
Così il team viene chiamato a Fraser’s Hill, in Malesia, dove una giovane coppia occidentale, Ian (William Miller) e Martha (Malin Crépin), chiede disperatamente aiuto per lottare contro fenomeni inspiegabili. All’inizio sembra tutto una bufala, ma nello scantinato della magione Jules ha una esperienza terrificante e il team si rende conto di avere a che fare con i fenomeni paranormali più potenti da loro sperimentati.
Vengono subito installate telecamere di sorveglianza e sensori in tutta la casa, ma le entità presenti nella casa si scatenano, seminando panico e distruzione…

Don’t Look at the Demon: un horror derivativo che cita tutto il citabile del genere
In questa pellicola coesistono tradizioni religiose cristiane e orientali, cosa di per sé apprezzabile, anche se l’operazione è stata fatta in modo stereotipato e superficiale.
Brando Lee si è poi divertito a citare innumerevoli film del genere horror. Personalmente ho molto apprezzato un personaggio analogo a quello di Loyd, il mitico barista dell’Overlook Hotel di Shining, uno dei capolavori di Stanley Kubick, che in Don’t Look at the Demon è ovviamente condito in salsa malese.
Anche lo stile del film è ibrido, strizzando l’occhio sia al found footage alla Paranormal Activity, sia a pellicole molto più tradizionali, come L’Esorcista.
Peccato che l’ambientazione malese sia stata in definitiva lasciata sullo sfondo, nonostante l’inserimento di tradizioni e nomi locali nella storia raccontata, utilizzando peraltro attori e personaggi principalmente occidentali.
Al racconto principale si affiancano dei flash back sull’oscuro passato di Jules, i cui poteri le hanno giocato brutti scherzi nell’infanzia, e la sua tormentata vita sentimentale, con la possibile formazione di un triangolo amoroso all’interno della Skeleton Crew. Un supplemento di narrazione che non è stato gestito molto bene.
La sceneggiatura in generale non è eccelsa, con dialoghi ridondanti e il collegamento tra l’infanzia di Jules e le possessioni malesi nel presente che avrebbe dovuto trovare una spiegazione esaustiva in un finale alquanto confuso. Peccato.
Gli attori hanno fatto quello che hanno potuto per dare spessore ai loro personaggi, purtroppo alquanto stereotipati e bidimensionali. Il problema con questi horror strutturalmente derivativi è la difficoltà nel mantenere una tensione efficace nel pubblico, relegando agli jump scare il compito di dare qualche emozione in più.
Nel complesso il film si lascia comunque guardare, anche perché la durata è stata contenuta nella canonica ora e mezza, scelta che permette a mio avviso di rendere meglio digeribili anche pellicola non eccelse.
Del resto non credo che fosse nelle intenzioni di Brando Lee di realizzare un capolavoro indimenticabile, quanto invece di girare un onesto prodotto commerciale, giocando con gli stereotipi del genere e introducendo elementi della religiosità orientale. E ci è riuscito.